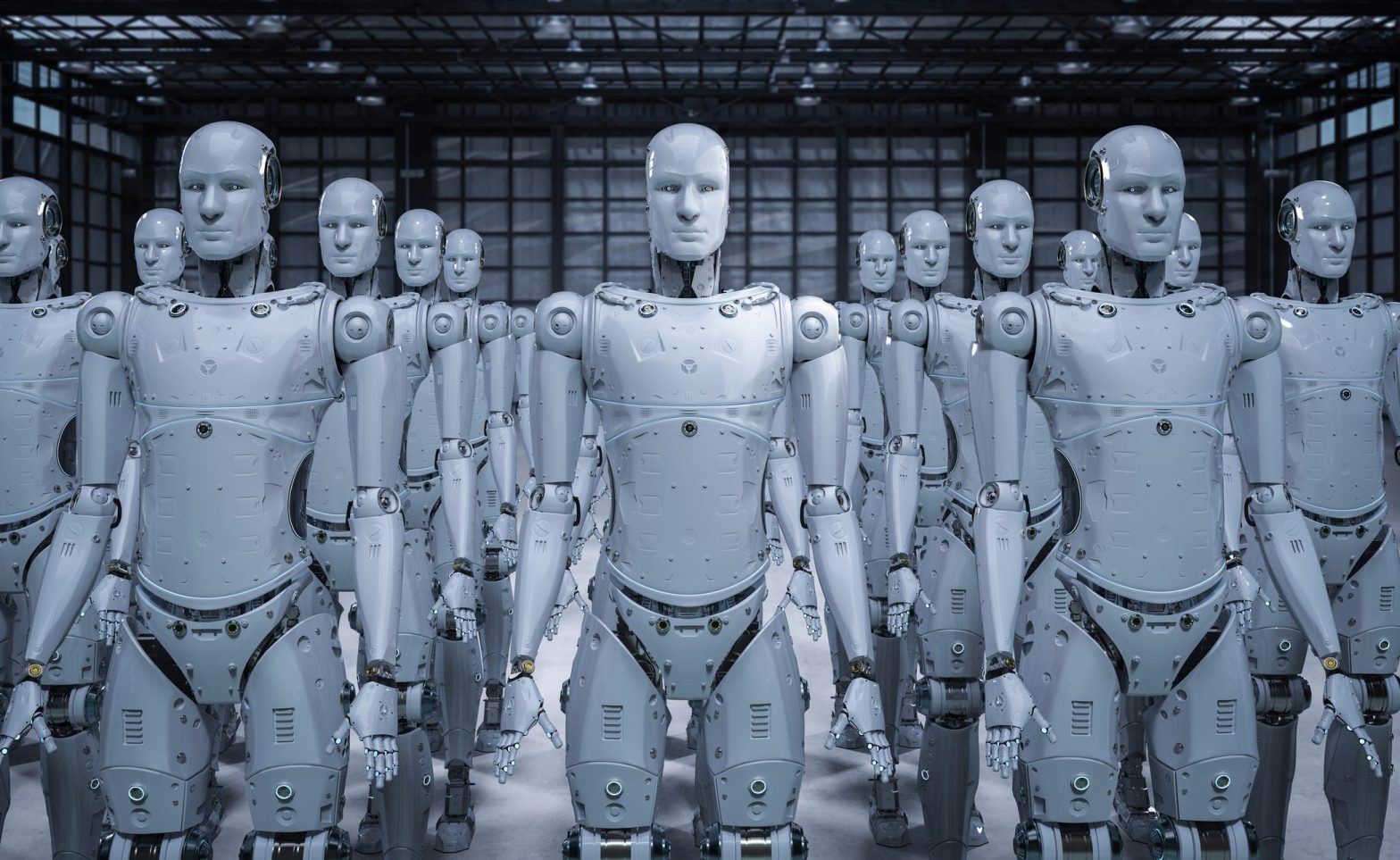di Salvatore Fiorentino © 2024
Come spesso accade in letteratura, non finisce mai di suscitare riverberi culturali, politici e financo storici il celebre scritto polemico di Leonardo Sciascia, pubblicato su “Il Corriere della Sera” del 10 gennaio 1987 ed intolato “I professionisti dell’antimafia“. Perché, come si intende ora dimostrare “al di là di ogni ragionevole dubbio”, proprio di scritto letterario si tratta, con tutti i pregi e i limiti che ciò comporta. E il non aver tenuto in debito conto questa peculiarità ha di fatto consentito l’ingenerarsi di una ridda di equivoci presto sfociati nelle strumentalizzazioni avverso chi sacrificava sé stesso per difendere lo Stato. Va tuttavia riconosciuto come ad una lettura retrospettiva, alla luce dell’accumularsi degli eventi accaduti negli ultimi trent’anni, si presenti più agevole il discernimento rispetto a quella che poteva essere poco più che un’impressione a caldo a fronte di un testo che doveva apparire dirompente in quel momento, alla fine degli anni ’80, in cui si varcava presso l’opinione pubblica di massa il confine – il “Rubicone”, per usare una metafora cara a Giovanni Falcone – tra la narrazione leggendaria della mafia e l’accertamento giudiziario della sua effettiva sussistenza. Del fatto che l’articolo di Sciascia sia in verità da considerare niente meno che un testo letterario, un’appendice ai suoi romanzi incardinati nei tre elementi invarianti (la Sicilia, la Mafia e l’Uomo delle istituzioni) in perenne mutuo conflitto, vi sono “molteplici, univoci e concordanti indizi”, tali da costituirne una “solida prova”. E se talvolta, come riteneva Silas Flannery (il riferimento ad Italo Calvino per il tramite di un suo personaggio, come si vedrà, non è casuale) riscrivere la parola d’altri è l’unico modo per cominciare a scrivere, potrà allora darsi che riscrivere le proprie parole è probabilmente un espediente per tornare sui propri passi o quanto meno il pre-testo per ritornare a calcare la “scena del delitto”.
I.
Donde il primo indizio (ne basteranno tre, com’è d’uopo), primo anche secondo l’ordine espositivo dell’articolo in commento, ma tale soprattutto perché talmente evidente “da servire a coloro che hanno corta memoria e/o lunga malafede“, e ciò sia detto solo per parafrasare la vis polemica sciasciana. Indizio primario che va pertanto riconosciuto nell’esercizio di una tecnica tipicamente letteraria, quella dell’intertestualità all’incipit di un novellare, qui realizzata mediante l’autocitazione di due importanti passi, ripresi da “Il giorno della civetta” e da “A ciascuno il suo“, tesi ad evidenziare appunto quel perenne dissidio la cui drammaticità si svela nella condizione esistenziale dell’Uomo che, pur raggiungendo ed a costo di sforzi eccezionali la consapevolezza della ragione del male e quindi dei rimedi per estirparlo, si trova tuttavia solo ed impotente con la soluzione in mano, ma senza mai riuscire a realizzarla. Che in verità non si tratti di mero indizio, ancorché primario, ma di “prova regina”, ci autorizzerebbe a ritenerlo quanto lo stesso Sciascia afferma (confessio est regina probatio) con espresso rinvio alle suddette notevoli autocitazioni: “la penso esattamente come allora, e nei riguardi della mafia e nei riguardi dell’antimafia“. E comunque, il ricorso all’intertestualità va oltre l’autocitazione, evocando grandi autori che evidentemente popolano il panorama letterario dello scrittore di Racalmuto, come Verga, Pirandello, Manzoni, e tra questi non sembri eccentrico il riferimento anche a Guttuso, dato che la poetica sciasciana può a buon diritto considerarsi “visuale” se giunge sino ad assumere “la Sicilia come metafora del Mondo”.
II.
Nel passare a trattare del secondo indizio, concorrente alla dimostrazione della tesi che ci occupa in questa sede, occorre preliminarmante ricordare come un testo letterario, per quanto attinga alla fonte della “finzione”, sia per questo più “veritiero” di qualsivoglia altro testo che si riproponga – come si insegna nelle scuole di giornalismo, salvo poi quasi sempre disattenderlo nella pratica professionale – il crisma dell’oggettività dei fatti pretendendo peraltro di confinare ogni soggettività nel collaterale campo delle opinioni. Sicché le raffigurazioni, incontrovertibilmente letterarie, con cui Sciascia illustra il suo scritto appaiono “più” vere come possono esserlo quelle di un romanzo, ossia descrittive di una realtà che ancora sfugge alla consapevolezza della generalità dei lettori, ma di cui già si manifestano i segni di immanenza nel divenire della storia e che solo uno sguardo precorritore riesce a cogliere. Come non ritenere così “vera” la caratterizzazione, “per esempio“, dell’Uomo politico al passo con i tempi: “un sindaco che per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi – in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei – come antimafioso: anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra, si può considerare in una botte di ferro. Magari qualcuno molto timidamente oserà rimproverargli lo scarso impegno amministrativo; e dal di fuori. Ma dal di dentro, nel consiglio comunale e nel suo partito, chi mai oserà promuovere un voto di sfiducia, un’azione che lo metta in minoranza e ne provochi la sostituzione? Può darsi che, alla fine, qualcuno ci sia: ma correndo il rischio di essere marchiato come mafioso, e con lui tutti quelli che lo seguiranno“. Nessuno, col senno del poi, negherebbe oggi la “verità” di questo passo, ma neppure che esso potrebbe essere a pieno titolo un brano di uno dei romanzi di Sciascia.
III.
Ed infine siamo al terzo indizio, non ultimo rispetto ai precedenti ma necessariamente conclusivo. Occorre premettere che esso tocca il rapporto tra storiografia e letteratura, ed in particolare la differenza del punto di osservazione che lo storico e il letterato utilizzano per posare lo sguardo sullo stesso oggetto d’indagine, con tutto ciò che ne consegue all’esito di quest’ultima. Se non può esistere – così come è illusorio pretendere di separare nettamente i fatti dalle opinioni – una linea tranciante che possa separare la visione dello storico da quella del letterato, può tuttavia dirsi che quest’ultima non esige il rigore metodologico nella “archeologia” (nell’accezione, con Foucault, di ricerca oltre l’approccio epistemologico) delle fonti che appartiene alla prima, mentre si alimenta principalmente attraverso la “noesi” (intesa, con Husserl, come esperienza vissuta), ossia dell’insieme degli atti di comprensione rivolti all’oggetto dell’esperienza, quali la percezione, l’immaginazione ed il ricordo. Ciò vale a dire che se, per un verso, la visione del letterato è “più” vera entro una prospettiva a-storica o a-tecnica, diremmo universale, per altro verso la stessa non può ritenersi altrettanto attendibile ove circoscritta ad un preciso episodio, e come tale limitato nel tempo e nello spazio. Difatti, entro tale contingenza il respiro grande della narrazione non può spiegarsi, venendo così a prevalere la specificità dei saperi, la tecnica, tanto della storiografia quanto, ad esempio, del diritto in tutte le sue articolazioni: sicché le interpretazioni superficialmente fondate e persino audaci di fatti storici o politici risulteranno accettabili se offerte da un letterato, mentre non si potrà certo perdonare ad uno storico la produzione di una storiografia romanzata. E di ciò, tornando al caso in esame, se ne ha evidenza nel corposo carteggio intercorso tra Italo Calvino e Leonardo Sciascia (67 lettere dal 1953 al 1981) dal quale emerge l’entusiasmo del Maestro per le abilità letterarie dello scrittore siciliano, ancorché con qualche titubanza sulle interpretazioni politiche e storiche.
IV.
Ciò posto, con specifico riferimento a “I professionisti dell’antimafia“, vanno rilevate due ricostruzioni/interpretazioni di fatti storici e politici che ricollegano, per mezzo di un “jump-cut” alquanto audace, l’antimafia al tempo del fascismo all’antimafia contemporanea (alla data dell’articolo), con incursioni tanto nel campo della storiografia quanto in quello del diritto costituzionale (rectius: ordinamento giudiziario). Per quanto si dirà, tali interpretazioni non possono tuttavia ritenersi, dal punto di vista a-letterario, convincenti e per certi versi neppure corrette sotto il profilo tecnico-disciplinare. In primo luogo, le perplessità scaturiscono dalla qualità della fonte storiografica da cui Sciascia dichiara di attingere (un libro di Christopher Duggan, dal titolo “La mafia durante il fascismo“), che si riconduce alla scuola di Denis Mack Smith, di larga notorietà presso il grande pubblico, ma non ritenuta in ambito scientifico tra le più autorevoli se non addirittura, da alcune parti, additata di superficialità ed indulgenze verso interpretazioni convezionali e rappresentazioni stereotipe per quanto riguarda in particolare la Sicilia. In secondo luogo, appare intrinsecamente debole se non del tutto forzata la conclusione a cui lo scrittore siciliano mostra di giungere sulla scorta di una siffatta fonte: “l’antimafia è stata allora strumento di una fazione, internamente al fascismo, per il raggiungimento di un potere incontrastato ed incontrastabile […] perché talmente innegabile appariva la restituzione all’ordine pubblico che il dissenso, per qualsiasi ragione e sotto qualsiasi forma, poteva essere facilmente etichettato come ‘mafioso’ “. Così come altrettanto forzata appare la trasposizione all’attualità della precitata conclusione: “Morale che possiamo estrarre, per così dire, dalla favola (documentatissima) che Duggan ci racconta. E da tener presente: l’antimafia come strumento di potere. Che può benissimo accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e sprito critico mancando“. Debolezze e forzature, quelle evidenziate nello scritto sciasciano, che traspaiono non tanto (e non solo) dall’ “esempio ipotetico” del “sindaco antimafioso” di cui si è già trattato sopra, quanto (e soprattutto) dall’esempio “attuale ed effettuato” della nomina di Paolo Borsellino a capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.
V.
E non poteva scegliersi esempio più “veramente” fuori luogo di quello anzidetto, il che non lascia infine alcun margine di dubbio sulla obbligatorietà, “contrariis reictis”, di collocare l’articolo in esame perlomeno nel campo eminentemente letterario, pena la destituzione di ogni suo fondamento e valore, il che sembrerebbe commettere un torto eccessivo nei confronti del maestro di Regalpetra. Sciascia infatti, avventurandosi in un terreno a lui non certo congeniale, quello dei complessi meccanismi delle nomine dei vertici degli uffici giudiziari da parte del C.S.M., insorge, tuttavia non cogliendo nel segno, contro la decisione dell’Organo di autogoverno della magistratura, additandone addirittura la motivazione che, invece del tutto correttamente, privilegia la competenza specifica rispetto al mero parametro dell’anzianità: “rilevato, per altro, che per quanto concerne i candidati che in ordine di graduatoria precedono il dott. Borsellino, si impongono oggettive valutazioni che conducono a ritenere, sempre in considerazione della specificità del posto da ricoprire e alla conseguente esigenza che il prescelto possegga una specifica e particolarissima competenza professionale nel settore della delinquenza organizzata in generale e di quella di stampo mafioso in particolare, che gli stessi non siano, seppure in misura diversa, in possesso di tali requisiti con la conseguenza che, nonostante la diversa anzianità di carriera, se ne impone il “superamento” da parte del più giovane aspirante“. Per infine concludere con un monito di cui appare difficile se non impossibile comprendere le ragioni dell’amara indignazione: “i lettori, comunque, prendano atto che nulla vale di più in Sicilia, per fare carriera nella magistratura, del prendere parte a processi di stampo mafioso“. Verrebbe da chiedersi quali fossero, secondo la visione di Sciascia, i processi più importanti e delicati, soprattutto in una fase storica incandescente, come quella che dal maxiprocesso contro Cosa nostra avrebbe condotto alle stragi di Capaci e via D’Amelio, da celebrare in Sicilia oltre quelli per reati di mafia, e per quali altri meriti, se non quelli professionali e collegati alla specifica competenza, i magistrati dovessero avanzare in carriera. Ma sono domande a cui non ci sono risposte, nè potevano mai esserci, perché in fondo scrivere romanzi sulla mafia non è come morire per combatterla. “Tutto è incominciato con quell’articolo su i professionisti dell’antimafia“, disse non a caso, profondamente amareggiato, Paolo Borsellino il 25 giugno 1992 presso la biblioteca comunale di Palermo, consapevole che da li a poco “tutto sarebbe finito”.
(5 maggio 2021)