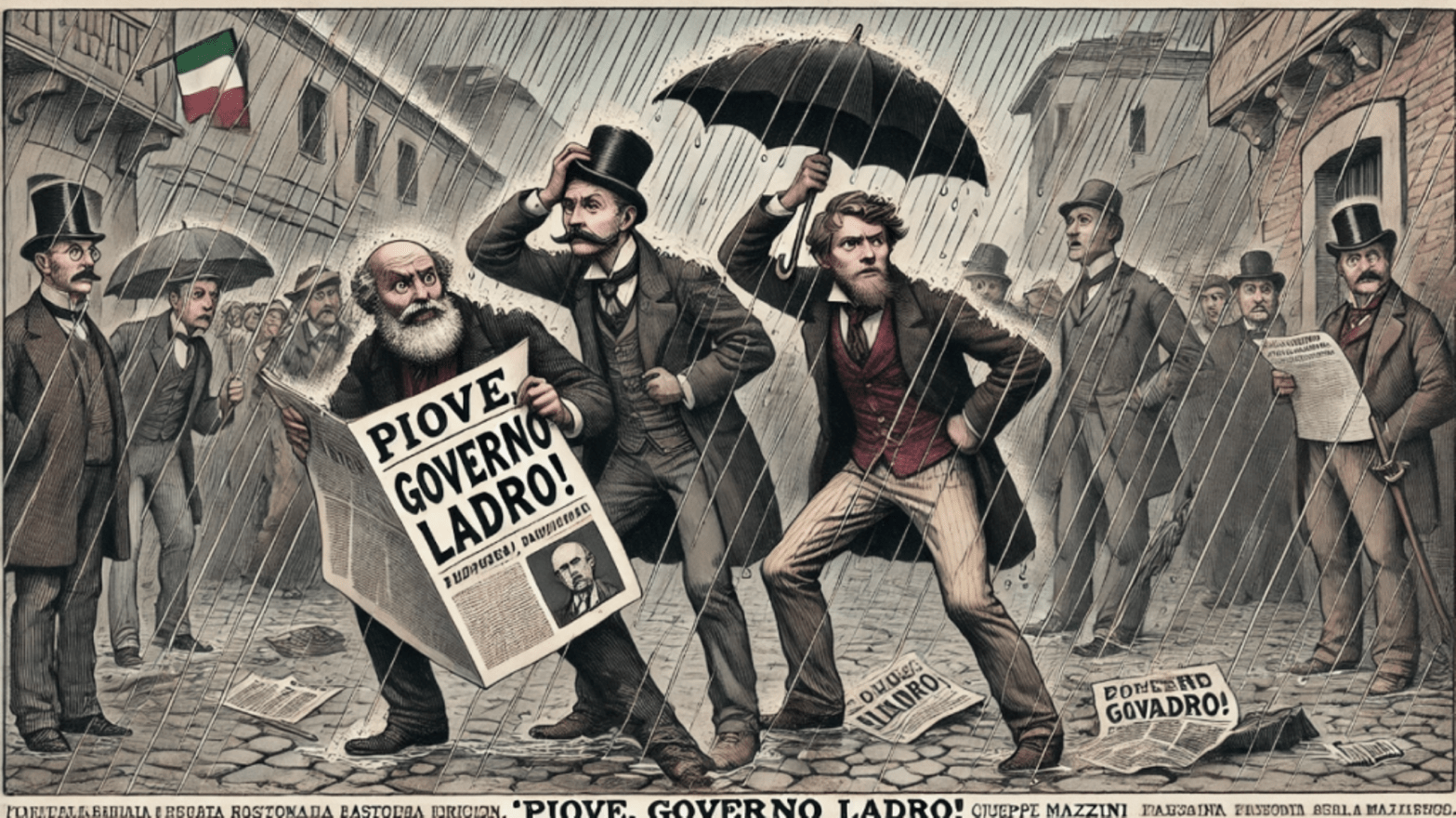di Salvatore Fiorentino © 2025
La storia non si ripete mai in modo eguale, nei suoi ricorsi che puntualmente si ripresentano. Ma se la storia è magistra vitae, seppur rimasta senza scolari come avvertiva Gramsci, essa sconta il grave limite di non essere “veritiera”, dato che è scritta dai dominatori (che non sono i vincitori) di una data epoca. In altri termini la storia può “ammaestrare”, ma non è in grado di svelare la verità, che non è mai una e una sola (non lo è neppure una retta per due punti nelle geometrie non euclidee), ma si moltiplica secondo i virtualmente infiniti punti di vista. Da ciò l’importanza basilare del “dialogo”, affinché questi punti di vista divergenti (la metafora della città di Leibniz lo illustra eloquentemente) possano essere composti in un disegno a più dimensioni, secondo precise convenzioni, ossia accordi, che permettano l’armonia delle diverse note che ciascuno, dal proprio punto di ascolto, sente come intonate anche se all’altro non pervengono come tali.
Come ha osservato Pepe Mujica – statista d’esempio per tutto ciò che si pone agli antipodi della concezione occidentale della società informata sul denaro e sul potere fine a sé stesso – è facile avere rispetto per chi la pensa come noi, ma dobbiamo imparare che il fondamento della democrazia è il rispetto per chi la pensa diversamente. Ossia la radice del rifiuto verso ogni dittatura, dove il “pensiero” di pochissimi, se non di uno, deve essere fatto proprio, volenti o nolenti, da tutti gli altri, pena l’ostracismo, la persecuzione, l’eliminazione civile e persino fisica. Le dittature non possono sussistere se vi è dialogo tra le componenti della società, mentre esse “fioriscono” nei momenti in cui le società si disgregano per il venir meno del collante valoriale che permette di comporre in una complessiva armonia le diversità e contraddizioni di cui ciascun individuo è naturalmente espressione. Sicché le dittature sopprimono le diversità e le democrazie le compongono.
Ecco che la vera essenza delle dittature non è tanto la privazione delle libertà, quanto la soppressione delle diversità o, ancora più sottilmente, la possibilità che queste diversità possano connettersi tra loro e formare una rete dialogante che come tale è produttiva di nuovo senso, ossia di cultura, in sintesi di quelle “magnifiche sorti e progressive” di cui scriveva Giacomo Leopardi, erroneamente considerato uno dei tre grandi pessimisti dell’Ottocento europeo insieme a lord Byron e Arthur Schopenhauer. Ecco che ci avviciniamo alle “verità” non tanto con gli insegnamenti della storia quanto con quelli della letteratura, ed in particolare della poesia, essendo che quest’ultima, come ha dimostrato Paul Ricoeur nel suo saggio “La metafora viva”, è produttiva di un nuovo senso, ossia di una potenza vitale generatrice di un punto di vista più elevato e nel contempo più profondo, che ci permette di comprendere una visione sempre più ampia della realtà che ci circonda.
Sia il modello di società capitalistico che quello delle società del comunismo reale si basano sul conformismo, ossia sulla soppressione delle diversità. Se il primo dei due ha infine prevalso apparentemente sul secondo, è solo perché è stato più evoluto nel costruire la gabbia entro cui imprigionare ogni possibilità che le diversità potessero effettivamente svilupparsi. Non è stato difatti necessario privare palesemente la libertà di parola, di espressione, di professione, mentre è stato sufficiente aver distratto le masse popolari per un verso mediante falsi obiettivi, da rincorrere all’infinito dietro l’incentivo di una gratificazione concessa ogni tanto, e per altro verso moltiplicando i motivi di conflitto all’interno delle stesse, secondo l’imperituro divide et impera, anche attraverso l’agitazione degli spauracchi di presunti o veri nemici dell’apparente benessere economico raggiunto, in verità per la maggior parte consistente in beni superflui quali surrogato dei valori essenziali.
Nel momento in cui la ricerca della felicità è stata spostata dalle persone alle cose, si è compiuto l’inganno, con la materializzazione delle vite e la conseguente ossessione per la ricerca del denaro oltre il ragionevole limite e del potere quale strumento per ottenere il primo a dismisura. Se solo si fosse compreso Heidegger, quando avvertiva dei pericoli del sacrificio della “ars” a favore della “téchne”, non si sarebbe giunti, oggi, ad uno degli abissi della storia dell’umanità. E’ solo a causa del prevalere della “tecno-logia” rispetto alla “scienza” (che implica in sé la co-scienza) che oggi si idolatrano i nuovi tycoon globali come Soros e Musk, solo per citare i maggiori, schierati su fronti opposti, ma che perseguono il fine di “schiavizzare l’umanità”; e ciò tanto da “destra” che da “sinistra”, categorie queste ormai desuete e svuotate di ogni significato oltre che senza rilevanza. Tutti gli altri, da Trump a Meloni, sono solo comparse di cartapesta nel teatro del mondo.