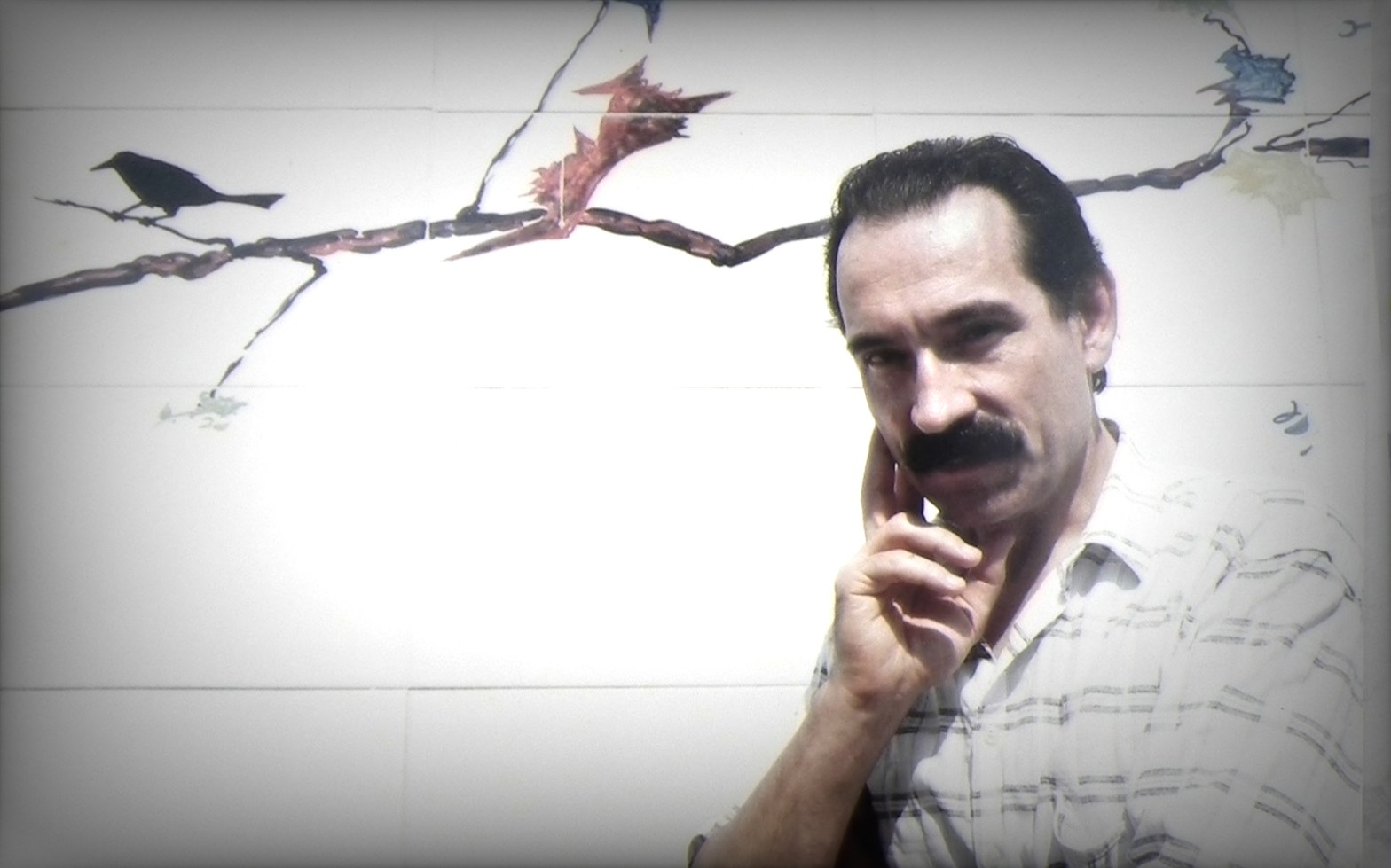di Salvatore Fiorentino © 2021
Tra le tante polemiche letterarie, spesso niente altro che sterili diatribe se non vere e proprie faide tra “addetti ai lavori”, quella che vede ora Leonardo Sciascia soccombere nei confronti di Sebastiano Vassalli in un improbabile “referendum” tra lettori più o meno avvertiti, sembra invece riportare allo scoperto una questione di largo interesse generale, già affrontata in passato (come l’articolo sotto riportato illustra), ma rimasta irrisolta e che non si presenta di facile né attuale soluzione, mentre si finisce per gettare benzina sul fuoco delle parole a suo tempo intinte in un insolito sardonismo da Giuseppe Fava nel celebre scritto “Sciascia Alien”.
Sicché qualcuno – ahilui ! – resta sorpreso ed amareggiato dal fatto che il “popolo” abbia preferito Vassalli a Sciascia in questa singolar tenzone tra scrittori che vedono la stessa realtà, quella del ruolo della mafia nella società siciliana, da punti di vista inconciliabili, se non del tutto opposti ed in mutuo conflitto. In particolare, se ne dolgono, annunciando pubblicamente la resa incondizionata ed il ritiro immediato da ogni impegno letterario e civile, gli “sciasciologhi” di professione, ossia i luminari di rango accademico che al maestro di Regalpetra hanno dedicato, senza risparmio di energie, i migliori anni della loro vita lavorativa, ricevendone invero il riflesso degli onori ed allori. Probabilmente, se ne dorranno anche i tanti lettori appassionati, soprattutto quelli rimasti colpiti dall’inprinting liceale di frasi come “l’italiano non è solo l’italiano, ma è il ragionamento”, oppure “la Sicilia è la metafora del mondo”. E Sciascia il suo profeta: Alien.
Ne “Il giorno della civetta”, forse anche oltre le intenzioni dell’autore, la “sicilitudine” è cristallizzata nella figura dell’unica donna che vi compare, messa in sottordine tanto nel romanzo quanto nella realtà che nello stesso si intende rappresentare, dato che alla fine consiste in un distillato etereo, volatile, quale si dimostra quel camminare sulla corda sospesa tra la volontà di ribellione e quella dell’accomodamento, che finisce per generare una stasi, quasi una paralisi, della coscienza, che non concede nulla né in un senso né nell’altro, in quanto unica via d’uscita per la sopravvivenza, che non è né l’omertà né il suo contrario, ma un modus vivendi che le contiene entrambe, in un miracolo di conciliazione.
Condizione in cui tutti sono vinti tranne l’autore, che non disdegna di compiacersene, sacrificando le sue comparse (nessuno può dirsi protagonista, né il Capitano Bellodi né don Mariano, né tanto meno Rosa Nicolosi o il povero Parrineddu), guadagnando un’illusoria salvezza, che lo erge come tale anche al cospetto dei lettori, che invece non hanno scampo.
Agli antipodi di questa concezione “sciasciana” si colloca “Il Cigno” di Sebastiano Vassalli, romanzo sul “caso Notarbartolo” accolto con snobismo se non con malcelato fastidio, da personalità dell’intellighenzia siciliana del calibro di Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e Manlio Sgalambro. Eppure viene messo a fuoco il tipico personaggio politico siciliano, ambiguo sino all’autoassoluzione dal peccato di chiedere, anche tacitamente, sostegno alla mafia, il che dà la chiave di lettura per comprendere la realtà della “borghesia mafiosa”.
(21 marzo 2020)
QUEL CIGNO DEVE MORIRE
di Simonetta Fiori
Una telefonata nel pomeriggio a Comiso, punta meridionale della Sicilia. Professor Bufalino, ha letto il romanzo ‘siciliano’ di Sebastiano Vassalli, Il cigno? “No, guardi, non ho tempo. E quando ce l’ho prediligo i classici”. Risaliamo un po’ più a Nord, verso Palermo: cambia il prefisso, non la musica. Professor Sgalambro, ha dato un’occhiata all’ultimo romanzo di Vassalli? Parla del caso Notarbartolo, della mafia, della cultura omertosa … “No, non l’ho visto. Ma perché, ne vale proprio la pena?”. Rintracciamo Vincenzo Consolo a Parigi: “Se ho letto Il cigno? No, ho avuto altro da fare. E poi di Vassalli non ho mai letto niente. Anche se stavolta mi toccherà”.
Gesualdo Bufalino, Manlio Sgalambro, Vincenzo Consolo: curiosa reazione, quella di tre intellettuali siciliani, di fronte a un romanzo che parla di mafia. E ne parla in modo originale, senza subire la fascinazione del grande Mostro, l’arcaica e rozza Medusa che pure ha suggestionato scrittori sensibili; ne denuncia al contrario l’humus culturale in cui affonda le radici la piovra mafiosa. “Forse i guai della Sicilia”, conclude un personaggio, “sono causati da questa immensa distanza che c’ è tra le parole e le cose … Due mondi lontanissimi e completamente estranei! Qui chi agisce a suo vantaggio è sempre nel giusto, qualunque cosa faccia; mentre la ragione, che dovrebbe essere il punto di riferimento e la guida di tutte le azioni umane, è condannata a perdersi in un labirinto di sofismi dove l’essere e l’apparire, il bene e il male, il lecito e l’illecito sono intrecciati così strettamente tra di loro da non poter essere divisi, e comunque sono soltanto astrazioni”.
Ma qual è la storia narrata nel Cigno? Riassumiamone la trama. Siamo in Sicilia, anno 1893. Viene ammazzato dalla mafia il commendator Emanuele Notarbartolo, ex direttore generale del banco di Sicilia. I sospetti cadono sull’onorevole Raffaele Palizzolo, deputato filocrispino ed espressione del ceto affaristico che era stato ostacolato dalla rigida gestione del credito imposta da Notarbartolo. Palizzolo sarà condannato al primo e secondo dibattimento. Al terzo processo, l’assoluzione. La sentenza viene accolta in Sicilia da clamorosi tripudi: nuvole di coriandoli, gagliardetti e stelle filanti per il rientro di Palizzolo detto “Il Cigno”, un entusiasmo tale “che nemmeno nei vecchi festini di Santa Rosalia s’era vista una cosa del genere”.
Morale della favola (anche se il romanzo è tutt’ altro che moraleggiante): intellighenzia, borghesia professionale, ceti operai solidarizzano con il mafioso, simbolo dell’orgoglio isolano contro i pregiudizi del Nord. Una rappresentazione accettabile? La prima riserva viene da uno storico contemporaneista che insegna a Pisa (siciliano per parte di padre), Paolo Pezzino, autore di saggi sulla mafia. “Il romanzo di Vassalli non mi è piaciuto: il suo tono è piuttosto incline al grottesco, il suo sguardo privo di effettiva curiosità, i personaggi tendono alla macchietta, con i mafiosi che rumoreggiano a tavola, dandosi grandi manate sulle spalle. L’eccessivo distacco dalla materia impedisce all’autore di penetrare la complessità e la drammaticità della vita dell’isola, che viene appiattita soltanto su un solo carattere, lo spirito omertoso. Forse, per penetrare in quel mondo di mafiosi dove ‘si considera il resto del mondo composto soltanto di nemici’, è necessario un maggior grado di condivisione della materia, per comprendere prima ancora che per denunziare”.
Sulla stessa linea il “milanesissimo” Gigi Speroni, autore di una ricostruzione de Il delitto Notarbartolo che esce in questi giorni da Rusconi: “Vassalli racconta soltanto una delle due Sicilie: quella che plaude a Palizzolo. Tralascia invece la Sicilia che scende in piazza silenziosa per celebrare Notarbartolo, vittima della mafia. Racconta la società collusa, sopprime totalmente la figura di Leopoldo Notarbartolo, figlio guardiamarina di Emanuele, che lottò tenacemente per undici anni al fine di ottenere giustizia al padre. La scelta di Vassalli si risolve in una demonizzazione del popolo siciliano. Quanto alla veridicità del suo racconto, Il Cigno è una storiona di mafia a truci tinte, infiorata da episodi assolutamente inventati”.
“Per Vassalli i siciliani sono tutti mafiosi”, crede di poter sintetizzare un giovane regista siciliano, Pasquale Scimeca, autore per il Festival di Venezia di un film sul movimento dei fasci in Sicilia (Il giorno di San Sebastiano). “Il Cigno è frutto di un pregiudizio, ideologico e razzistico: la Sicilia come un paese intimamente colluso con il potere criminale. Questo mi dà fastidio, è una falsità, come dimostrano i fasci siciliani, i movimenti del dopoguerra o la rivolta morale dei Falcone e Borsellino. La verità e che, quando hanno tentato di ribellarsi, i siciliani sono stati lasciati soli”.
I toni incandescenti sorprendono un sociologo che di mafia s’intende, il professor Pino Arlacchi, calabrese di Gioia Tauro. “Non capisco tutto questo scalpore. Vassalli rappresenta un modo di raccontare la mafia più freddo e distaccato, che è alternativo a quello di Sciascia, tutto interno al modo di sentire siciliano. Aggiungo: il suo è un modo salutare di rappresentare il fenomeno mafioso, che ci vaccina contro certo ‘sciascismo’. Se qualche esasperazione c’è, la trovo nella rappresentazione bozzettistica e di maniera degli uomini d’onore, non certo nella denuncia della collusione tra politica centrale, mafia e sicilianità. La ricerca storica e le testimonianze dei pentiti ci consentono di dire che, dall’età di Crispi all’era Andreotti, i più importanti politici siciliani dell’ area governativa sono stati tutti collusi con la mafia. O sono stati essi stessi uomini d’onore. Dove sta allora la forzatura?”.
“Vassalli”, conviene Nando Dalla Chiesa, “ha saputo fotografare egregiamente proprio il sicilianismo come ideologia di copertura del fenomeno mafioso: quel vittimismo di fondo secondo cui ‘quelli del Nord ci vogliono trasformare tutti in mafiosi’ . Il meccanismo di autoscagionamento è rimasto identico nei decenni: all’ epoca crispina come nell’età andreottiana. Vassalli ci ha restituito molto abilmente il sofisma dell’uomo politico siciliano, Palizzolo, che alla fine si persuade di essere innocente. Tante volte, quando mi sono ritrovato davanti a dei Palizzolo più recenti, ho pensato: questi credono davvero che la mafia non esista, che la mafia sia un’invenzione del Nord per criminalizzare il popolo siciliano. In fondo, è lo stesso ragionamento della migliore intellettualità siciliana, rappresentata nella sua punta più alta da Sciascia. Non è stato lui a trasformare gli antimafiosi in uomini ingiusti e carrieristi?”.
Alt: toccare Sciascia può diventare pericoloso. Chi l’ ha fatto (lo stesso Vassalli), è stato accusato di infierire sui cadaveri. Perché succede questo? Dalla Chiesa: “Vede, ci sono dei meccanismi che si ripetono, anche se in forme più nobili. Ogni volta che si parla di Sicilia, di Sciascia, e lo si fa in termini critici, scatta una reazione di lesa sicilianità: come è accaduto quando Vassalli ha imputato agli scrittori siciliani una sorta d’ omertà (ndr: Consolo reagì attribuendo a Vassalli ‘l’aggressività della neonata letteratura leghista’). In fondo, gli intellettuali siciliani non fanno altro che riproporre oggi in versione letteraria quei ‘comitati pro Sicilia’ che Vassalli irride nel romanzo. Non capisco. Consolo, la Sellerio, sono persone limpide. Perché inalberarsi?”.
Pino Arlacchi: “Ho riletto di recente Il giorno della civetta e A ciascuno il suo: una grandissima delusione! Ci ho ritrovato la magnificazione del potere mafioso, una visione nichilistica e profondamente cinica sulla possibilità di sconfiggere la mafia. Per non dire di quella noticina che compare nel Giorno della civetta: ho passato molto tempo a cavare a cavare, per rendere irriconoscibili i personaggi di cui parlo, perché in Italia scherza coi fanti, ma lascia stare i santi. Bene: è un messaggio di una codardia civile spaventosa. Per molto tempo, l’intellighenzia siciliana ha creduto che la mafia fosse il destino della Sicilia (da Gaetano Mosca a Tomasi di Lampedusa fino a Sciascia). La polemica sui carrieristi della antimafia non è stata una scivolata momentanea di uno scrittore vecchio e stanco, ma rappresenta la quintessenza della sua cultura. Il grande merito culturale di Falcone e Borsellino è stato, invece, l’aver dimostrato che la mafia non è il destino della Sicilia. Che la mafia non è onnipotente. La mafia può essere sconfitta. E forse il grande merito di Vassalli è di vaccinarci contro lo sciascismo”.
“L’intellettuale siciliano”, si difende Manlio Sgalambro, un filosofo che pubblica da Adelphi, “è disperatamente metafisico, tende a trasferire su un piano universale fatti contingenti e iperfisici come la mafia. A uno scrittore civile ciò può sembrare diserzione, tuttavia è una valutazione sbagliata”. Non c’ è il rischio di cadere nella trappola del cinismo? “Ma metafisica e cinismo sono in qualche modo sinonimi …”.
[articolo tratto da “La Repubblica”, 11 dicembre 1993]