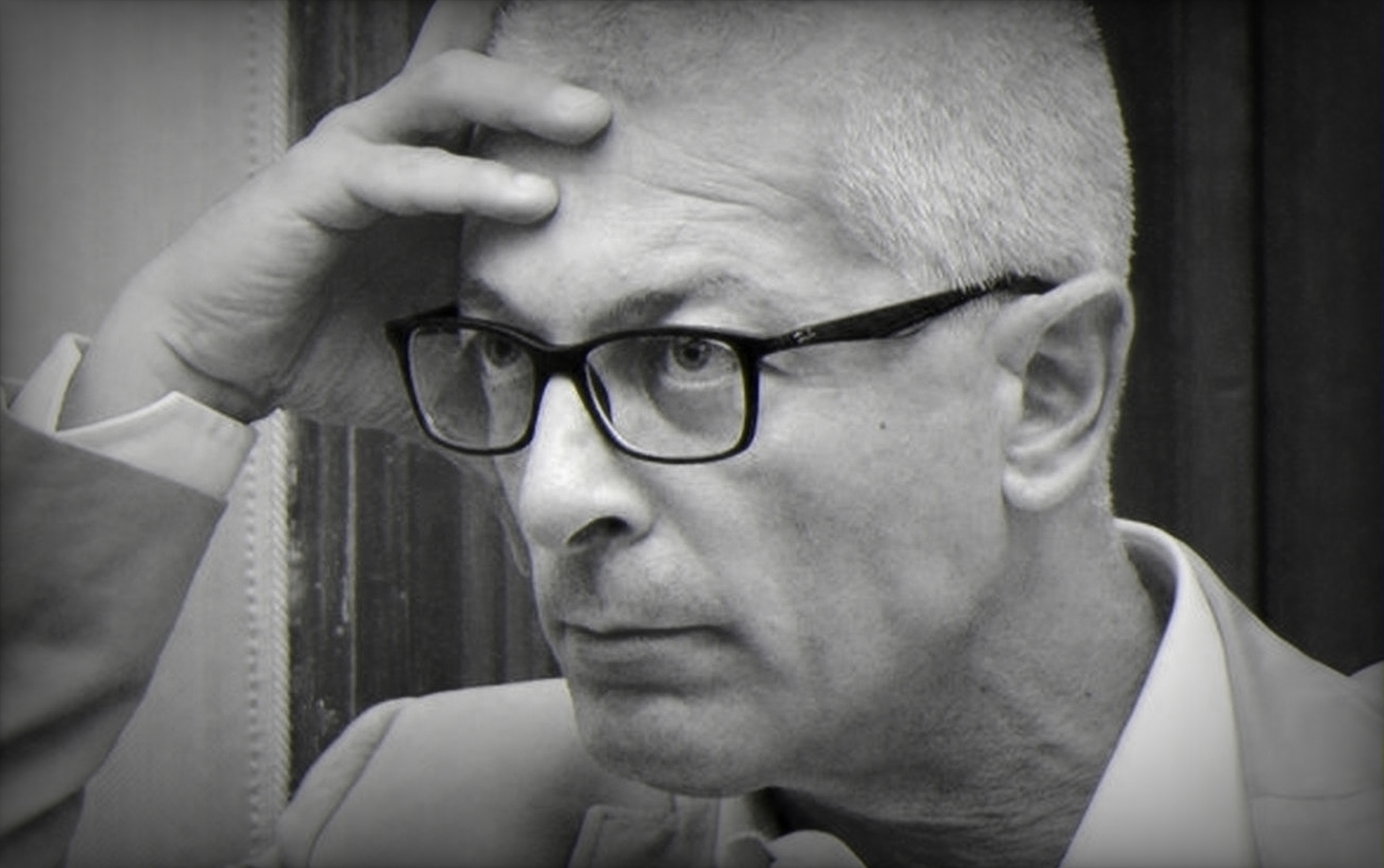di Salvatore Fiorentino © 2021
L’antimafia non smette di stupire. Dopo lo scontro tra Claudio Fava e Giuseppe Lumia, per lo più condotto con il primo a testa alta e ben visibile e con il secondo nell’ombra a tirare i fili delle controfigure cresciute alla sua corte, si assiste alla discesa in campo dei “Cappuccetto Rosso” dell’antimafia, che vorrebbero convincere l’opinione pubblica che la Nonna (l’ex senatore Lumia) non è assolutamente quel lupo che il Cacciatore (il presidente della Commissione regionale antimafia Fava) vorrebbe smascherare una volta per tutte.
Sappiamo che è più facile ingannare l’audience piuttosto che convincerla che è stata ingannata, ed è per questo che gran parte del cosiddetto “popolo antimafia”, che nutre un sincero e genuino animo legalitario, viene fuorviato, dando credito a chi non lo merita. Eppure basterebbe leggere, con attenzione e senza pregiudizi, le relazioni della Commissione regionale antimafia per capire, senza che possano residuare dubbi, come l’antimafia dei Montante e dei Lumia sia non altro che una gigantesca messa in scena.
Superfluo spiegarlo per Montante (i procedimenti giudiziari parlano da soli), necessario farlo invece per Lumia, dato che l’ex senatore antimafia, ad oggi, seppur sodale di Montante, non è stato oggetto dell’interesse di alcuna delle procure della repubblica isolane. Quale contributo abbia dato Lumia alla lotta alla mafia, dopo venticinque anni di militanza nella Commissione nazionale antimafia, non lo ha ancora capito nessuno. E non è possibile criticarlo, giammai attaccarlo, altrimenti si rischia di essere associati al boss di turno.
(3 ottobre 2020)
IL PARADOSSO DEL BOSS ATTANASIO CHE PLAUDE ALL’ ANTIMAFIA DI FAVA
di Fabio Repici
Era chiaro a tutti che il gigantesco testacoda sarebbe arrivato. Solo stupidi e disonesti potevano far finta di non accorgersi di ciò che stava accadendo. E, alla fine, il disastro è arrivato.
È sempre fuori da ogni galateo citare sé stessi, ma non posso evitarlo, per dimostrare che l’avviso, per i presunti distratti, era già stato lanciato. Io personalmente ne avevo scritto sei mesi fa, in un pezzo (“Il senso di Ventura Mary per Paolo Borrometi”) nel quale avevo rilevato una inedita fenomenologia culturale: in quell’antro infernale denominato Facebook, le prese di posizione del presidente della commissione antimafia regionale Claudio Fava, rilanciate da un avvocato di Scicli a nome Bartolo Iacono, erano sostenute con gioia sconfinante nel tripudio (e nell’odio, pericoloso e sguaiato, verso Paolo Borrometi) da parenti e amici di mafiosi di Vittoria.
Ma quello era niente, rispetto allo spettacolo che ha fatto irruzione sulla scena pubblica qualche giorno fa. La notizia ci è arrivata dalla testata online siracusana «Diario1984», fondata e diretta da Pino Guastella. Poiché l’informazione era molto peggio che clamorosa e poiché la fonte era molto più che scivolosa (Pino Guastella fu arrestato a febbraio 2018 e poi rinviato a giudizio, attualmente in corso, per associazione a delinquere insieme agli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, al magistrato Giancarlo Longo, al faccendiere Alessandro Ferraro e al prestanome Davide Venezia per i fatti del cosiddetto “sistema Siracusa”; secondo la D.d.a. di Messina, Guastella col suo giornale conduceva, pagato da Amara, campagne diffamatorie contro pubblici ministeri che Amara non era riuscito a comprare, come Marco Bisogni e Tommaso Pagano), ho aspettato due giorni in attesa di una rettifica, una smentita, un minimo alito di contrarietà. E invece niente.
L’articolo pubblicato l’1 ottobre dal giornale di Guastella ha questo titolo: «La Repubblica gli arriva senza le tre pagine dell’articolo “Fu davvero mafia?”: esposto di Attanasio».
Il protagonista della storia si chiama Alessio Attanasio, capo del clan mafioso Bottaro-Attanasio imperante a Siracusa. Per il momento risiede al carcere di Tolmezzo al 41-bis. Insomma, un boss pericolosissimo ritenuto responsabile, oltre che di mafia, di omicidi, estorsioni e altro. Il giornale di Guastella ci informa che Attanasio «ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Udine e al Tribunale di Sorveglianza di Trieste contro la Direzione della Casa Circondariale di Tolmezzo per aver sottratto le pagine 19-20-21 del quotidiano La Repubblica nelle quali si parla del presunto attentato compiuto ai danni del presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci», come tutti sanno firmato da Attilio Bolzoni in un’inchiesta coordinata e firmata anche da Carlo Bonini. «Diario1984» aggiunge che Attanasio aveva già protestato per il divieto posto dalla direzione del carcere alla ricezione dell’articolo di Bolzoni e che il magistrato di sorveglianza di Udine gli aveva pure dato ragione. Ma nonostante ciò la sua ansia di lettore era rimasta frustrata.
Ora, tutti sappiamo cosa fosse quell’articolo: l’ennesima ricostruzione peggio che malevola sull’attentato compiuto ai danni di Giuseppe Antoci nella notte del 18 maggio 2016, con l’ennesima riproposizione delle teorie della Commissione regionale antimafia presieduta da Claudio Fava, secondo cui quell’attentato potrebbe essere stato una vera e propria «messinscena» nel quadro di un’orditura politica (e certo non un attentato di mafia), con l’aggiunta di grossissime defaillance degli investigatori e della D.d.a. di Messina tutte utili a non disvelare la «messinscena». L’articolo di Bolzoni, cioè, riproduceva, e condivideva con trasporto morale, il contenuto della relazione che sull’attentato ai danni di Antoci la commissione presieduta da Fava licenziò il 2 ottobre 2019, giusto l’anno scorso, in una data in cui altri rivolgevano il pensiero alla memoria di Adolfo Parmaliana.
Quindi, il capomafia Attanasio, detenuto al 41-bis a Tolmezzo, bramava di leggere il reportage di Bolzoni. Del resto, il boss è già dottore e in procinto di prendere la seconda laurea. Ovvio che apprezzi le buone letture. E Bolzoni, indiscutibilmente, è una penna raffinatissima. Ergo, era ingiusta, anche perché Attanasio non aveva alcun divieto in proposito, la decisione della direzione di impedirgli quella lettura con la motivazione che «nell’articolo con il titolo “Fu davvero mafia?” si riportano “informazioni di cronaca giudiziaria e di cronaca nera della regione siciliana riguardante un agguato mafioso, utili al fine di conoscere lo stato dei rapporti tra clan di stampo mafioso nel territorio di provenienza del detenuto”».
Quel che ho dovuto rileggere più volte per convincermi di non avere le traveggole è il testo dell’esposto del boss contro la direzione del carcere, riportato fra virgolette da Guastella: «contrariamente a quanto asserisce la Direzione del carcere, in quelle tre pagine si parla di episodi inquietanti che di certo non hanno nulla a che fare con la mafia e del fatto che la Sicilia, dopo le stragi, è prigioniera di una grande impostura, c’è un’Antimafia fasulla e pericolosa rappresentata da Confindustria che è già finita nelle indagini della procura e della squadra mobile di Caltanissetta, c’è un sistema di potere marcio alla Regione, ci sono interessi colossali per lo smaltimento dei rifiuti. Si fa riferimento in particolare alla messinscena, al finto attentato del 17 maggio 2016 ai danni del presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, nominato nel giugno 2013 da Rosario Crocetta, il governatore della Sicilia invischiato nelle scorrerie del vicepresidente nazionale di Confindustria Antonello Montante condannato nel 2018 a quattordici anni per associazione a delinquere insieme a esponenti dei servizi segreti e poliziotti, così come accertato dal Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto e dalla Commissione parlamentare antimafia siciliana presieduta da Claudio Fava il quale afferma “su quella vicenda abbiamo avuto conferma che non si è trattato di un atto di mafia da fonti giudiziarie assolutamente attendibili attraverso conferme dirette o indirette di magistrati”».
Sì, il boss di Siracusa parla col verbo di Claudio Fava. E qui viene pure spontaneo chiedersi per quale motivo sia stato fatto il ricorso per avere quell’articolo se Attanasio lo ricorda a memoria fin nei dettagli: misteri del 41-bis. Schematizzando senza alcun commento, nel pensiero del capomafia Alessio Attanasio i cattivi sono, nell’ordine, «l’Antimafia fasulla e pericolosa» (sbizzarritevi sui nomi), Giuseppe Antoci, Rosario Crocetta, Antonello Montante ed esponenti dei servizi segreti e poliziotti a lui legati, mentre i buoni sono Attilio Bolzoni, Claudio Fava, la Procura di Caltanissetta, la Squadra mobile di Caltanissetta, il Commissariato di pubblica sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto (ovviamente, quando era diretto dal vicequestore, ora avvocato, Mario Ceraolo) e la Commissione regionale antimafia.
Cioè: Attanasio, capomafia, disprezza «l’Antimafia fasulla e pericolosa» e ammira, aggiungerei io, «l’Antimafia veridica e benefica» rappresentata dalla Commissione antimafia presieduta da Claudio Fava.
La mafia che plaude all’Antimafia (quella buona, ça va sans dire). Ci sarebbe voluto Umberto Eco per commentare questa fenomenologia, emersa in questi tempi cupi da Sicilian Tabloid.
Ma, in questo impazzimento generale, molto più banalmente, rispetto alle riflessioni che avrebbe fatto Eco, mi pongo due domande: 1. C’è qualcuno che ancora può far finta di non vedere ciò che accade sotto gli occhi di tutti? 2. C’è qualcuno che inizia a provare almeno un po’ di vergogna?
[articolo apparso su “Stampalibera.it”, 3 ottobre 2020]
(POST)
di Paolo Borrometi
In questi mesi sono stato insultato, offeso, diffamato. Mi è stato detto di tutto.
Non potendo riuscire a smontare ciò che ho scritto nei miei articoli in tutti questi anni, hanno tentato la via della delegittimazione. Strategia purtroppo molto conosciuta in Sicilia, quella del discredito per sporcare l’immagine di una persona.
È stato difficile, anzi difficilissimo, rimanere in silenzio ma il mio rispetto per gli inquirenti (ai quali ho subito denunciato) è massimo. Adesso finalmente posso parlare.
Nei giorni scorsi, infatti, sono stato sentito dal Consiglio di disciplina dei giornalisti e ho fornito prova documentale incontrovertibile che il famoso “appello” contro lo scioglimento di Scicli fu pubblicato il 15 marzo 2015.
Il sito, appena prima della mia audizione in Commissione antimafia regionale siciliana, ha subìto un gravissimo hackeraggio (anzi molto di più e ancora in corso) finalizzato a far credere che io avessi retrodatato quella pubblicazione.
Quindi che fossi un imbroglione.
Volete sapere come si confeziona una trappola?
Si entra illegalmente in un sito, si prende un articolo del 2015 e lo si elimina. A quel punto se ne crea un altro, di contenuto identico a quello eliminato, e lo si pubblica nel 2020, ma con data 2015 in modo da farmi passare per un imbroglione.
Sembra facile, ma servono mani esperte.
Ovviamente tutto provato, e non solo questo, e documentato al Consiglio di disciplina e denunciato agli inquirenti, che spero individuino presto (e puniscano duramente) i responsabili.
Tutto ben studiato, tutto perfetto. Così anche la Commissione antimafia siciliana è caduta in questa trappola.
Una vicenda terrificante. Hanno tentato di distruggere me e prendere per fessi tutti!
Fatto sta che, come dissi nell’immediatezza, io quell’articolo lo avevo pubblicato senza ombra di dubbio.
Ho basato tutta la mia vita sulla credibilità, tutta. E non avrei permesso a nessuno di sporcarla.
La mia faccia è una e una sola. Non si scherza con la vita delle persone.
Grazie per essermi stati accanto, può servire tempo, ma la verità arriva sempre!
[post pubblicato sul profilo Facebook di Paolo Borrometi, 25 settembre 2020]